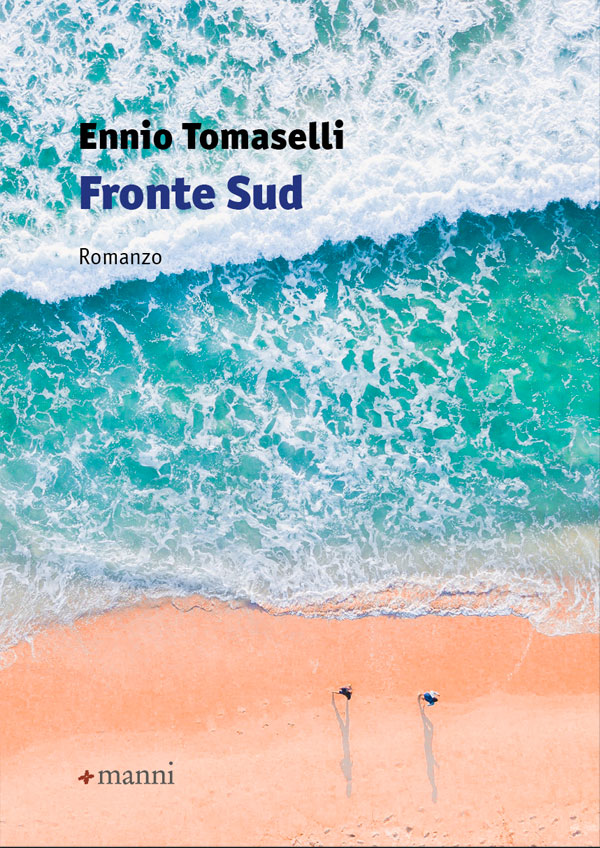di Lisa Ferrari e Maria Roccella, 1B.
Quest’anno l’autore dell’incipit per il progetto “Staffetta di scrittura” a cui ha partecipato la 1B del Liceo D’Oria non è solo un romanziere, ma anche un ex magistrato minorile: Ennio Tomaselli.
Nato presso Firenze, si è trasferito con la famiglia a Torino, nel quartiere delle Vallette. Il magistrato abita tuttora nel capoluogo piemontese con la moglie Rosamaria. Si è laureato in giurisprudenza nel 1978 e ha superato il concorso d’ingresso in magistratura, per diventare giudice penale del tribunale di Torino dal 1978 al 1986. Ha partecipato anche ad alcuni processi in corte d’Assise, e nell’86 è diventato giudice del tribunale per i minorenni. Tomaselli, forse anche per aver lavorato come giudice minorile, si sente a suo agio in presenza dei ragazzi e ci tiene a valorizzare questa esperienza. Si è sempre impegnato ad incontrare i giovani e parlare con loro, anche se a distanza. Il 3 dicembre 2024 la classe 1B del liceo classico Andrea D’Oria di Genova ha avuto la possibilità di contattare lo scrittore tramite videoconferenza meet, per porgli alcune domande.
Ha sempre voluto diventare un magistrato, oppure se n’è convinto strada facendo?
Ho deciso di diventare magistrato alle scuole superiori, in quinta liceo, perché fino ad allora ero molto indeciso su quale carriera intraprendere. Mio padre faceva parte del corpo di polizia e forse la mia scelta è stata indirizzata anche dall’ambiente in cui sono cresciuto. All’esame di maturità mi è stato chiesto da un membro esterno cosa volessi fare dopo l’università ed è stato allora che ho espresso per la prima volta questo mio desiderio.
Com’è stata per lei l’esperienza del liceo?
Ho frequentato il classico e a dire la verità, il primo anno ho avuto non pochi problemi…sono stato rimandato in latino, matematica, greco e italiano. Anche dopo aver studiato tutta l’estate mi hanno bocciato, ma grazie al sostegno dei miei genitori sono riuscito ad andare avanti e alla fine ho lasciato la scuola con il massimo dei voti. Dopotutto a volte nella vita ci sono momenti di difficoltà, ma si possono sempre superare con la fiducia in sé stessi e il supporto dei propri cari.
In quanto magistrato lei deve aver affrontato casi di ragazzi che avevano completamente perso la loro strada. Qual è stato il caso più importante e difficile che abbia mai incontrato?
A dire la verità tutti i casi che ho affrontato sono importanti per me, anche quelli meno complessi. Ho sempre cercato di non essere superficiale mentre analizzavano i diversi problemi, perché al di là dell’apparente semplicità della situazione nulla si deve dare per scontato. Sia che stessi scrivendo la sentenza (ad esempio del caso “Erika e Omar”) sia che stessi esaminando una pronuncia sullo stato di adottabilità, non ho mai smesso di sentirmi responsabile del minore che mi stava davanti. Infatti sbagliare su una di queste pronunce avrebbe potuto portare a delle conseguenze psicologiche irreversibili per la persona in questione.
La carriera di magistrato sembrava esserle molto a cuore, quindi per quale motivo ha scelto di abbandonarla per diventare scrittore?
La legalità è stata senza dubbio una parte importantissima della mia vita, ma ad un certo punto ho sentito il bisogno di abbandonarla. Ho optato per il pensionamento anticipato perché mi era parso di aver completato un certo percorso di lavoro e di vita e quindi di potermi permettere, essendo già nelle condizioni per accedere alla pensione, di sperimentare qualcosa di diverso e, magari, “diversamente utile”. Ormai passavo perfino le vacanze a scrivere sentenze! Non avevo più tempo da dedicare a me stesso e alle mie passioni: così ho deciso di lasciare la magistratura per esplorare nuove forme di linguaggio con cui esprimermi.
Facendo sedimentare i ricordi della mia carriera, ho scritto quattro romanzi e un saggio intitolato “Giustizia e ingiustizia minorile”. In pratica ho continuato a partecipare alla questione minorile, solo in un modo diverso e con maggiore tranquillità.

Anche la scrittura quindi è molto importante per lei: ma cosa significa per lei scrivere?
Secondo me la scrittura nasce dall’emozione, da quello che si vuole comunicare. Per me è molto importante esprimere la mia opinione per quanto riguarda la legalità ed è proprio per questo che sono diventato autore. I miei libri rispecchiano la realtà della vita, sono inventati ma realistici: penso che non riuscirei mai a scrivere un romanzo fantasy o di fantascienza. In essi ho narrato la storia di qualcun altro ma parlando di me: ogni scrittore alla fine racconta di sé nelle sue opere.
I libri in cui forse mi sono immedesimato di più sono stati quelli che fanno parte di una piccola trilogia, formata da Messa alla prova, Un anno strano e Fronte Sud. Il protagonista di questi romanzi è il magistrato Malavoglia, che rispecchia molto la mia esperienza personale. Alla fine dell’ultimo libro Malavoglia esce di scena, lasciando alle persone più giovani il suo posto, proprio come ho fatto io.


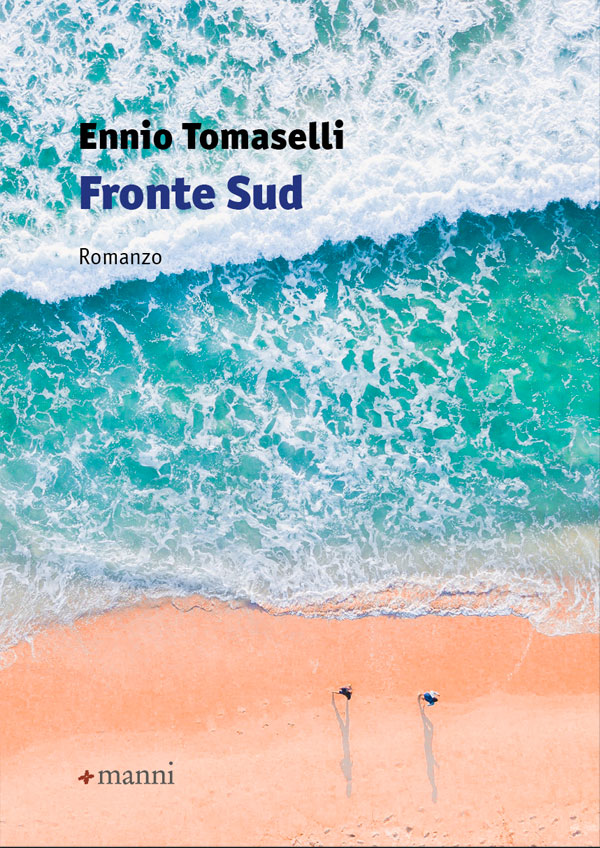
Avrebbe un messaggio da lasciare a queste nuove generazioni, signor Tomaselli?
Certamente…per voi andare avanti forse sarà difficile, ma il futuro è nelle vostre mani. Volevamo lasciarvi un mondo migliore ma non tutto è possibile. Però come dice un antico proverbio africano: “ognuno è responsabile degli occhi che guarda”. Per questo vi posso lasciare il mio più grande augurio di un domani luminoso.
Grazie mille per il pensiero. Comunque secondo noi lei e i suoi colleghi magistrati siete davvero riusciti a migliorare il nostro presente! Avete riscattato tante giovani vite, che altrimenti si sarebbero perse. Ci potrebbe raccontare come riusciva a gestire i colloqui con gli imputati?
In un processo minorile è necessario usare un linguaggio informale per favorire la comunicazione. Di solito preferisco l’uso del “tu” e cerco di non mettere soggezione al ragazzo che ho davanti. Trovo che sia molto utile chiedere l’opinione del minore sulla situazione, per sapere cosa ne pensa. In un processo dove l’imputato è adulto il tono usato è naturalmente più formale.
Secondo lei quanto è cambiata la giustizia minorile negli ultimi anni?
È cambiata molto. Nel settore civile, ad esempio, con maggiori garanzie complessive e in particolare, per i ragazzi, grazie a norme che ne prevedono o esigono l’ascolto, da una certa età in poi, nelle procedure i cui effetti sono destinati a ricadere su di loro. Parlo anche di procedure di particolare rilievo, come quelle di adottabilità e di decadenza di uno o entrambi i genitori dalla responsabilità (un tempo potestà) genitoriale.
E invece cosa accade nei casi in cui è il minore a compiere il reato?
Il minore ovviamente viene sottoposto ad un tribunale, viene stabilita una sentenza e se il ragazzo è colpevole di grave reato viene mandato in prigione. Tuttavia si tratta sempre di una condizione temporanea, anche se può durare per diversi anni non si tratta mai di una condanna a vita. In alcuni Stati si favorisce l’ergastolo anche per i minori ma la Corte Costituzionale ha stabilito che esso è incompatibile con la giustizia minorile. Questi ragazzi sono ancora giovani e nella maggior parte dei casi è possibile anche un buon reinserimento nella società.
Ma come si può prevenire il reato minorile secondo lei?
Per prevenire reati gravi come omicidi serve fin da subito un’azione all’interno della famiglia, il primo nucleo sociale, poi della scuola e delle associazioni educative. Ad esempio il volontariato è un buon modo di imparare ad agire per il bene degli altri.
E per quanto riguarda la sua esperienza con i migranti? Come mai ha basato l’incipit proprio su questo tema?
La migrazione è una realtà molto attuale e molto spesso sottovalutata. Le immigrazioni dagli altri Paesi sono ben più pericolose e segnano nell’anima le persone che le intraprendono. Ho preso ispirazione per il mio incipit, da un gruppo di volontari triestini che accolgono tutti i giorni i viaggiatori della rotta balcanica. Così, ecco, ho pensato di portare questo tema anche fra due ragazzi come potreste essere voi…che discutono in riva al mare.
Giusto, Gabriel e Alessandra, i due protagonisti dell’incipit, l’uno più indeciso e l’altra più determinata. Si aspettava che fosse Alessandra a diventare la protagonista dei capitoli successivi?
Certamente, Alessandra fin dal principio sembra la più coraggiosa e decisa a cambiare le cose. Secondo lei la migrazione non è una questione per politici o adulti ma per tutti, anche loro che sono ragazzi secondo lei possono fare la differenza!
Grazie mille per la sua disponibilità e la sua gentilezza nel rispondere alle nostre domande. Siamo sicuri che ricorderemo questo incontro con lei per molto tempo.















 Lo spettacolo include letture tratte da
Lo spettacolo include letture tratte da